E’ in libreria per le edizioni 'Il Mulino' il volume “Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale”, curato da Fabrizio Barca, già Ministro per la Coesione territoriale, e dall’economista Patrizia Luongo, frutto di tre anni di attività teorica e sul campo del Forum Disuguaglianze e Diversità, un’alleanza tra ricerca e organizzazioni di cittadinanza attiva.
La crisi Covid-19 ha reso eclatanti le gravi disuguaglianze che già esistevano prima della crisi, lo squilibrio di potere e voce tra le persone, i gravi errori nelle politiche del passato, e ha fatto crollare verità che sembravano intoccabili, prima fra tutte, quella che non ci sia alternativa a una società diseguale. Alla narrazione dell’inevitabilità delle disuguaglianze, ormai indifendibile alla prova dei fatti, ma ancora sostenuta da chi avversa un possibile cambiamento, il volume propone di contrapporre una strada alternativa concreta, fatta di visione e proposte, per immaginare e realizzare un futuro più giusto di prima, che aiuti a unire le forze per una mobilitazione sociale organizzata, necessaria al cambiamento.
Come evitare che gli squilibri di potere e di ricchezza crescano ancora? O che prevalga una dinamica autoritaria? Quali sono le cause delle disuguaglianze e le responsabilità della politica e delle politiche? È possibile indirizzare l’accelerazione della trasformazione digitale alla diffusione di conoscenza e alla creazione di buoni lavori? E come? Come far funzionare la 'macchina pubblica' e assicurare il confronto democratico sulle decisioni? Come assicurare dignità e partecipazione strategica al lavoro? Come affrontare la crisi generazionale?
Sviluppando le '15 proposte per la giustizia sociale' elaborate dal Forum Disuguaglianze Diversità, alleanza originale di cittadinanza attiva e ricerca, il volume offre una risposta a queste domande, concentrandosi in particolare sul cambiamento tecnologico, sul ruolo e il potere del lavoro e sulla crisi generazionale, ed avanzando proposte concrete per valorizzare i grandi centri di conoscenza italiani, per liberare e unire le forze dell’imprenditoria privata e sociale, della cittadinanza e del lavoro che animano i territori, per trasferire potere ai giovani, per ridare missione e spirito ai pubblici dipendenti.
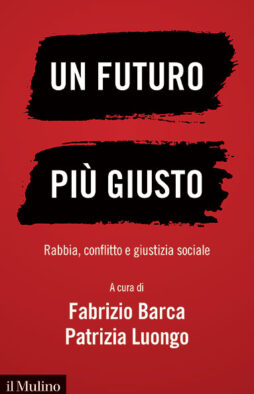
Abbiamo intervistato Patrizia Luongo e Fabrizio Barca, ‘vecchia’ conoscenza della città dell’Aquila avendo avuto, da Ministro, la delega alla ricostruzione del cratere 2009 e avendo lavorando, tra l’altro, alla strategia nazionale delle aree interne che, proprio in questi mesi, inizia a dispiegare i suoi primi effetti anche in Abruzzo; con loro, abbiamo sfogliato un libro che rappresenta un importante strumento di analisi e di lavoro per chiunque voglia contribuire a costruire un futuro più giusto e a lottare per averlo.
“A valle della presentazione delle 15 proposte del Forum per la giustizia sociale, il libro racconta di come ci siamo mossi per la ‘messa a terra’ di queste proposte lavorando con una serie di alleati che ci hanno fornito un contributo prezioso”, spiega Patrizia Luongo; “oltre le proposte, però, il volume offre anche una approfondita analisi sulle disuguaglianze e sugli scenari che possono aprirsi come conseguenza della crisi che stiamo vivendo. In realtà – svela Luongo – il libro l’avevamo terminato prima del diffondersi del coronavirus: tuttavia, in accordo con l’editore abbiamo ritenuto utile di aggiornalo con ulteriori riflessioni, analizzando l’impatto della pandemia non solo sul sistema sanitario ma sulle condizioni socio-economiche dei Paese”.
Da tempo, il Forum delle Disuguaglianze e delle Diversità sta lavorando ad una agenda politica radicale, oggi più che mai necessaria. E di questo si riflette nel libro, sin dal titolo: un futuro più giusto passa dal conflitto, dall’elaborazione comunitaria del senso di rabbia e di frustrazione diffuso tra le classi più deboli in un senso che sia costruttivo.
“Non ce n’è una di disuguaglianza esplosa in queste settimane, dall’assenza di collegamento digitale nelle aree interne all’enorme difficoltà che alcuni bambini, anche per il contesto familiare, hanno dovuto scontare nel raccogliere la sfida della didattica a distanza, fino alla incredibile differenza tra lavoratori, quelli tutelati e i 6-7 milioni che si sono ritrovati senza garanzie, a tempo determinato oppure irregolari, frutto di 30 anni di politiche sbagliate - per loro, siamo riusciti ad ottenere almeno un reddito di emergenza, con una battaglia condotta in prima linea anche dal Forum - che non fossero già manifeste”, sottolinea Fabrizio Barca.
“E non ci voleva molto a vederlo: non era difficile capire che la rabbia, la frustrazione che già si respiravano, la dinamica autoritaria che si percepiva, trovavano le loro fondamenta nelle disuguaglianze. Fino a che ci si sente impotenti, la rabbia resta tale e ci si convince che le cose, in fondo, non possano cambiare. E magari arriva qualcuno che utilizza quella rabbia per farti odiare chi sta ancora peggio di te, magari il migrante. Al contrario, se maturi il convincimento che un’alternativa esiste, allora puoi contribuire a costruire con altri un cambiamento che passa necessariamente dal conflitto, anima della democrazia. Vogliamo chiamarlo confronto accesso? Chiamiamolo confronto accesso: l’obiettivo del Forum è di fornire delle idee a questo confronto”, ribadisce Barca.
L’analisi delle tendenze prodotte da Covid-19 ci suggerisce che nulla è scritto, mette nero su bianco il Forum delineando tre scenari, tre progetti politici che possono compiersi.
Il primo, riprendere la strada correggendo le “imperfezioni”: l’obiettivo è tornare alla “normalità” pre-Covid-19 compensandone meglio le disuguaglianze, ma affidandosi agli stessi principi e dispositivi che le hanno prodotte, presentando la “digitalizzazione” come un processo univoco di progresso, promettendo “semplificazioni” e inibendo l’esercizio di discrezionalità da parte degli amministratori pubblici nell’assunzione delle decisioni, favorendo i rentier rispetto agli imprenditori, mortificando partecipazione strategica di lavoro e società civile, e scaricando su quest’ultima e sulla famiglia ogni ruolo di mediazione sociale.
Il secondo, accelerare la dinamica autoritaria in atto prima della crisi: l’ulteriore impoverimento, la rabbia e l’ansia per il domani vengono alleviate offrendo barriere che promettono una rassicurante “purezza identitaria”, nemici da sconfiggere (migranti, stranieri, diversi, esperti), uno Stato accentrato e accentratore pronto a prendere rapide decisioni e a sanzionare comportamenti devianti, senza la pretesa di un pubblico confronto.
Il terzo, cambiare rotta verso un futuro di emancipazione sociale. Per farlo, “c’è una questione di metodo fondamentale: il confronto”, spiega Luongo; “un confronto che sia realmente inclusivo e continuativo, che consenta a tutti di esprimere i propri sentimenti e le proprie necessità, anche accesso se necessario, a patto che sia costruttivo e porti a soluzioni che siano la sintesi di diversi punti di vista capaci di arricchire i modi in cui ragioniamo sulla distribuzione del potere e sul modo in cui viene utilizzato. D’altra parte, la crisi economica che seguirà alla emergenza sanitaria può rappresentare una miccia, un acceleratore di dinamiche già in atto. E’ vero che l’indice di Gini, quello che misura le disuguaglianze di reddito, è rimasto costante dagli anni ’80: è vero anche, però, che da allora ha smesso di scendere. Ciò significa che si sono ampliate le disuguaglianze di ricchezza, di accesso ai servizi fondamentali: nel lungo periodo, questo può scatenare rabbia e frustrazione. Sta a noi decidere che strada imboccare”.
L’immagine della biforcazione torna spesso, nel corso dell’intervista. “Apriamo biforcazioni”, ribadisce Barca; “facciamo alcuni esempi, per capirci: lo smart working, ma chiamiamolo piuttosto lavoro a distanza, può essere tutto e il contrario di tutto. Può rappresentare l’occasione per riorganizzare il lavoro, dare più forza, autonomia e responsabilità alla persona, ridisegnandolo in modo più motivante, oppure segnare il passo finale della ghettizzazione del lavoratore, della sua parcellizzazione. Ancora, la pedagogia a distanza: se si replicano sul web le modalità di lezione frontale è, di certo, impoverente e penalizza chi ha cattivi collegamenti internet o chi non ha una famiglia capace di riempire gli spazi che il digitale lascia inevitabilmente vuoti. Ma rappresenta senza dubbio una sfida all’insegnamento, al sistema pedagogico, raccolta da tanti insegnanti che si sono inventati modalità straordinarie di didattica a distanza: in questo modo, può diventare motivo di arricchimento”.
Sta a noi, continua Barca: “le crisi hanno la caratteristica di destabilizzare, di accelerare processi. Vado avanti. Assistiamo ad un rafforzamento delle grandi imprese digitali: vogliamo che ciò determini un ulteriore strumento di potere in mano a pochi, oppure vogliamo 'sfruttare' gli strumenti che stiamo imparando ad usare per alimentare discussioni, creare mutualismo a distanza che superi le divisioni di classi che fanno sì che ci si incontri in quei bar, in quelle piazze? Qui ci si incontra in una piazza aperta. Di nuovo, le biforcazioni possibili. Le nostre proposte si innestano su queste biforcazioni, a sinistra e non a destra. E non l’ho detto a caso”.
Proposte che sono ‘sul tavolo’, che si spera possano essere ascoltate e valutate.
“Come Forum abbiamo avanzato dei suggerimenti al Governo: a partire da così detto ‘Cura Italia’, a nostro avviso si potevano apportare dei miglioramenti e, poco fa, Fabrizio Barca faceva riferimento, per esempio, al Reddito d’emergenza su cui abbiamo molto insistito. Ora, è chiaro che con una quantità di risorse come quelle prospettate dal ‘Recovery fund’ – aggiunge Patrizia Lungo – bisognerà procedere avendo obiettivi chiari da perseguire, a medio e lungo termine, e non inseguendo l’emergenza. E’ con le azioni di ora che iniziamo a disegnare il futuro che si realizzerà nei prossimi anni. A partire dagli interventi per una efficiente sanità territoriale, passando per gli investimenti sulla scuola e sull’università che rischia un impatto assai negativo della crisi, fino al lavoro, iniziando a far emergere il sommerso e avvicinandolo allo Stato. Vanno identificati obiettivi chiari per poi trovare gli strumenti operativi migliori”.
Barca torna sull’importanza del confronto che, riconosce, “fino ad oggi non c’è stato; almeno, non c’è stato un confronto strategico con le parti organizzate che non va confuso con l’ascolto delle parti, una roba vecchia di vent’anni. Confrontarsi vuol dire avere una idea, metterla sul tavolo, discuterla, rivederla, aggiustarla a misura di territorio: l’Italia è il paese dei territori, delle periferie, dei centri minori, delle aree interne. Ci vogliono indirizzi, certo, che vanno calati a terra però dialogando con i sindaci - il pezzo più interessante della classe dirigente italiana - e con le organizzazioni di cittadinanza che, sui territori, possono contare più di quanto non facciano nell’astratto dialogo nazionale. E’ decisivo che i fondi che arriveranno non vengano utilizzati per grandi e magnificati piani d’investimento che cascano sulla testa dei cittadini, che non entrino nei canali di sempre, ristretti, di chi ha già deciso. Dobbiamo liberare, al contrario, le forze imprenditoriali e creative dei territori, l’impresa sociale e l’impresa privata: per farlo, dobbiamo ascoltare i progetti di vita di chi è stato più colpito, degli artigiani, dei piccoli imprenditori, dei ragazzi che facevano turismo e cultura e, in questo dialogo nuovo, vanno calate le idee generali”.
Barca è convinto che, nel prossimo futuro, le aree interne potranno ritagliarsi un ruolo significativo, “e lo diremo a fine mese in un dialogo col ministro Giuseppe Provenzano. Le aree interne hanno potenzialità in grado di rispondere alla nuova domanda. La caratteristica dello shock che abbiamo vissuto è di pesare sulle nostre preferenze: ci ha reso più consapevoli dei servizi che contano, del fatto che salute e welfare, per esempio, debbano camminare insieme; ci ha fatto capire che, forse, non è necessario fare quel viaggio fuori dal mondo quando a 30 o 60 km da casa ci sono posti straordinari per un turismo di prossimità; ci ha fatto riscoprire la filiera corta, l’urgenza di non dipendere da sistemi lontani per l’energia e il gas. Una nuova domanda, e sto parlando di capitalismo, cui le aree interne hanno la forza di rispondere”.
Anche per il lungo lavoro che si è costruito con la Strategia nazionale delle Aree interne, con la definizione di aree progetto che, oggi, “sono pronte, preparate, già istruite”. Ed in questo senso, ben venga la presa di coscienza di chi, come Stefano Boeri, ha prefigurato la possibilità di un ritorno ai borghi, “vicini o lontani dai grandi centri urbani: a patto, però – tiene a chiarire Barca – che i centri di competenza, pubblici o privati che siano, atterrino su una piattaforma che già c’è, e l’ho detto anche a Boeri. Non veniteci a raccontare di progetti altri, mettete a disposizione la vostra competenza dentro a territori che già sanno cosa vogliono. E’ una grande occasione, e va assolutamente colta”.
